Rialzati, Italia Un governo da barzelletta sta gestendo alla sua maniera una delle crisi più gravi del dopoguerra, impotente di fronte ad una situazione che non comprende. E’ in crisi un modello di sviluppo basato sulla globalizzazione e sulle sinergie imperfette. Il socialismo reale è stato dichiarato defunto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e con l’abbattimento della cortina di ferro. Potrebbe arridere stessa sorte al capitalismo? La questione non è così semplice da sciogliere. Se anche il capitalismo dovesse manifestare chiarissimi segni di cedimento e fosse vicino all’inizio di una caduta, la sua fine, per essere sancita, dovrà passare necessariamente attraverso un’alternativa valida, in mancanza della quale saremo tutti costretti a sopportarlo per un tempo indefinito, nella speranza, magari vana, che si autocorregga.
Quello che sta accadendo nei giorni nostri è una manifestazione alquanto chiara dell’impasse che la società occidentale ad impronta capitalista sta vivendo, riassumibile in un refrain ricorrente, una frase dal senso misterioso ed inafferrabile come una chimera, che si riverbera di bocca in bocca passando per quelle più autorevoli: cresciamo poco.
Siamo tutti adulti e da crescere (almeno fisicamente) non abbiamo più. Si parla del famigerato PIL, quanto tutti noi insieme produciamo in un anno. La litania che economisti, banchieri centrali, autorità politiche ripetono in continuazione non cambia.
Il Presidente della Repubblica Napolitano ha definito drammatici i dati sulla crescita, specie se visti in prospettiva e rapportati all’aumento del debito pubblico. L’Italia è come una grande famiglia indebitata fino all’osso che per anni ha fatto fronte alle sue esigenze ricorrendo ai prestiti, onorati fin quando il reddito del capofamiglia lo ha permesso. Oggi sembrerebbe che la nostra nazione sia prossima al tracollo economico. Per mantenere lo stesso tenore di vita siamo costretti a sopportare spese sempre maggiori senza riuscire a coprirle completamente, in più i nostri creditori incominciano ad avere seri dubbi sulla nostra solvibilità. Crescere diventa l’imperativo categorico, ma come si fa visto che nessuno ha trovato ancora la ricetta giusta?
L’Italia è una nazione particolarmente sfortunata. Somma a problemi antichi una classe di governo particolarmente inetta. L’esempio della cicala e della formica calza a pennello, solo che i destini contrapposti dei due insetti nella nostra nazione diventano guaio comune: da noi albergano insieme governanti cicale che hanno dato fondo alle scarse granaglie sottratte ai soliti noti, e formiche taccagne che si sono arricchite a spese di altri e che ora si chiamano fuori dal loro turno del dare, preferiscono far approdare il bottino in lidi più sicuri.
Sabino Saccinto Vers. pdf

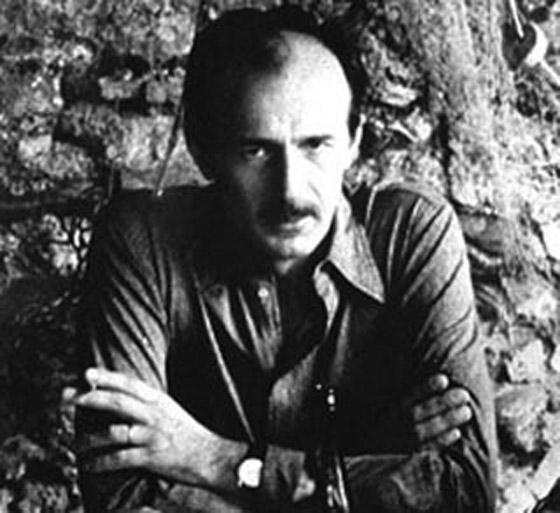

 Il socialismo reale è stato dichiarato defunto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e con l’abbattimento della cortina di ferro. Potrebbe arridere stessa sorte al capitalismo? La questione non è così semplice da sciogliere. Se anche il capitalismo dovesse manifestare chiarissimi segni di cedimento e fosse vicino all’inizio di una caduta, la sua fine, per essere sancita, dovrà passare necessariamente attraverso un’alternativa valida, in mancanza della quale saremo tutti costretti a sopportarlo per un tempo indefinito, nella speranza, magari vana, che si autocorregga.
Il socialismo reale è stato dichiarato defunto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino e con l’abbattimento della cortina di ferro. Potrebbe arridere stessa sorte al capitalismo? La questione non è così semplice da sciogliere. Se anche il capitalismo dovesse manifestare chiarissimi segni di cedimento e fosse vicino all’inizio di una caduta, la sua fine, per essere sancita, dovrà passare necessariamente attraverso un’alternativa valida, in mancanza della quale saremo tutti costretti a sopportarlo per un tempo indefinito, nella speranza, magari vana, che si autocorregga.